.
“Nomina sunt consequentia rerum”
[Giustiniano, Istitutiones (533 d.C) – II, 7, 3]
Inaugurata da alcuni governi degli ultimi venticinque anni, una certa ridefinizione dei servizi forniti dallo Stato repubblicano – a cominciare dal nome – è diventata comune e non più messa in discussione, e viene accettata con indifferenza o tranquillamente trascurata, evidentemente raffrontata ad altri, incombenti e ben più gravi problemi che lo affliggono.
In questo breve scritto ‘controcorrente’ vorrei rimarcare come la dicitura di alcuni Ministeri chiave del welfare italiano è, sembra definitivamente, cambiata: senza troppi clamori e con il fare tipico di chi desidera imporre una propria visione delle cose senza farsi troppa pubblicità e senza eccessive, faticose ed inutili discussioni, è stata adottata una soluzione di marketing politico sullo stile del famoso paradosso della rana e dell’acqua calda.
Recita infatti il noto apologo che una rana, immersa in acqua tiepida, mentre quella progressivamente si scalda non si ribella ma si adatta alle nuove temperature, resistendo senza reagire e restando infine bella e che bollita a propria insaputa: al contrario, fosse stata immersa in acqua bollente ne sarebbe immediatamente schizzata fuori, parzialmente abbrustolita ma ancora viva e vegeta.
Così è stata adottata la teoria di vendita del nuovo prodotto: si è preso il Ministero della Sanità, un bel nome che in chiaro dichiarava l’intenzione e l’obbligo costituzionale di garantire a tutti il diritto alle cure come servizio pubblico, gestito dallo Stato e pagato con l’apposito contributo dei cittadini che pagano le tasse e lo si è trasformato in qualcosa di simile ma niente affatto eguale, come il Ministero della Salute. Non sfuggirà al lettore il dettaglio che se la Sanità è un obiettivo da perseguire con le cure, la Salute è invece la condizione data di chi sta bene e non l’ha ancora persa, magari per mancanza di quelle stesse cure.
In gioco non c’è soltanto una dicitura, quindi, o banali considerazioni sul caso, il destino o imperscrutabili disegni che ci riguardino.
Non è stata infatti solo una innocua operazione di semplificazione poiché, a ben vedere, si è di fatto scambiata l’effetto sperato dell’esercizio di un diritto e di un impegno collettivo alla cura (la sanità) con lo stato per molti versi imponderabile delle condizioni fisiche legato alle responsabilità dei cittadini (la salute).
Come dire che mentre la ‘sanità pubblica’ è servizio a cura dello Stato, che trova vantaggioso e imprescindibile occuparsi della salute dei cittadini, la ‘salute’ è comunque uno stato dell’essere che dipende molto più dal caso e dai comportamenti privati, dei quali né lo Stato debba sentirsi ad alcun titolo responsabile né debba preoccuparsi eccessivamente degli interventi e delle cure.
Questo ha permesso ad alcuni assessori alla ‘salute’, appunto, di dichiarare in piena pandemia, che il sevizio pubblico di ospedalizzazione dei malati non poteva essere ‘pensato’ come ‘servizio per tutti’ né, tantomeno secondo la sua personale visione, dello stesso livello qualitativo per tutti i cittadini senza distinzione di rango e di censo (sic!).
L’assessore in questione è stato in seguito ‘dimissionato’ per manifesta inadeguatezza anche se nessuna rettifica alle sue dichiarazioni è stata mai presentata dai suoi sostituti.
Anche la scuola ha subito la stessa sorte: da Ministero della Pubblica Istruzione, con le medesime modalità è stato trasformato in Ministero dell’Istruzione.
La scomparsa dell’aggettivo ‘pubblica’ non è causale, poiché esso richiamava il dettato costituzionale di una scuola gratuita, pubblica ed aperta a tutti i cittadini.
Lo Stato repubblicano riteneva infatti utile, giusto e vantaggiosa l’istruzione di massa e le pari opportunità formative, sia a fini di sviluppo della cultura sia di sviluppo economico e politico. La scomparsa della dicitura, d’altra parte, prelude ad un cambiamento ideologico, quello che intanto prevede che l’Istruzione non sia una prerogativa di servizio del ‘pubblico’ e che in secondo luogo consista in uno ‘stato sociale’ che non può che essere asimmetrico, ovvero collimato con le opportunità garantite dal proprio censo e dalla condizione sociale.
In questa prospettiva l’istruzione sarebbe un diritto del cittadino nel senso che ciascuno ha il diritto di scegliere la propria e soprattutto di vedersela garantita dallo Stato con congrui finanziamenti e sostegno economico alle strutture private cui si rivolge. La Costituzione invece garantisce il diritto all’istruzione e alla formazione privata, purché senza oneri per lo Stato, in questa nuova visione (da qui il cambiamento di denominazione del Ministero) gruppi di cittadini riceverebbero una sorta di rimborso dallo Stato per la sua incapacità di garantire loro una formazione che sia esattamente coincidente con i propri dichiarati valori religiosi, morali, sociali ed economici.
Ad ognuno la propria scuola, tra i propri pari, dunque, omogenea culturalmente e in ambiente valoriale condiviso: al punto che alcuni pretendono una formazione privatissima come la home schooling, definitivamente chiarendo che non c’è limite pratico alla ricerca di un microcosmo identitario di appartenenza, finendo per pensare alla formazione come ad un fatto squisitamente privato e sostanzialmente a-sociale, cioè senza riferimenti alla dimensione relazionale e ai valori della convivenza.
Se con la Pubblica Istruzione si voleva rafforzare il principio che formazione e cittadinanza, veicolati dall’organizzazione pubblica, fosse compito e dovere dello Stato, che educa i propri cittadini alla parità formale, al rispetto delle regole di convivenza e alle pari opportunità di specializzazione, carriera e responsabilità professionali, con l’Istruzione in cui pubblico e privato si equivalgono, sono entrambe a carico dello Stato ma offrono servizi differenziati: accedere ad una particolare opportunità di istruzione secondo le proprie capacità di contribuzione aggiuntiva delle famiglie si ribadisce il principio che specializzazione, carriera e responsabilità di gestione siano riservati per legge naturale a chi se lo può permettere, in barba a tutti i propositi costituzionali e a barbosi principi morali tipici di quelli che si considerano, evidentemente, decadenti forme statuali come quelle democratiche e repubblicane.
[Scuola (7). La questione del nome – Continua]
Per gli altri articolo della stessa serie “Cerca nel sito”: Scuola con il numero progressivo tra parentesi (1), (2), ecc…
o attivare la ricerca per Autore: Santoro Bruno




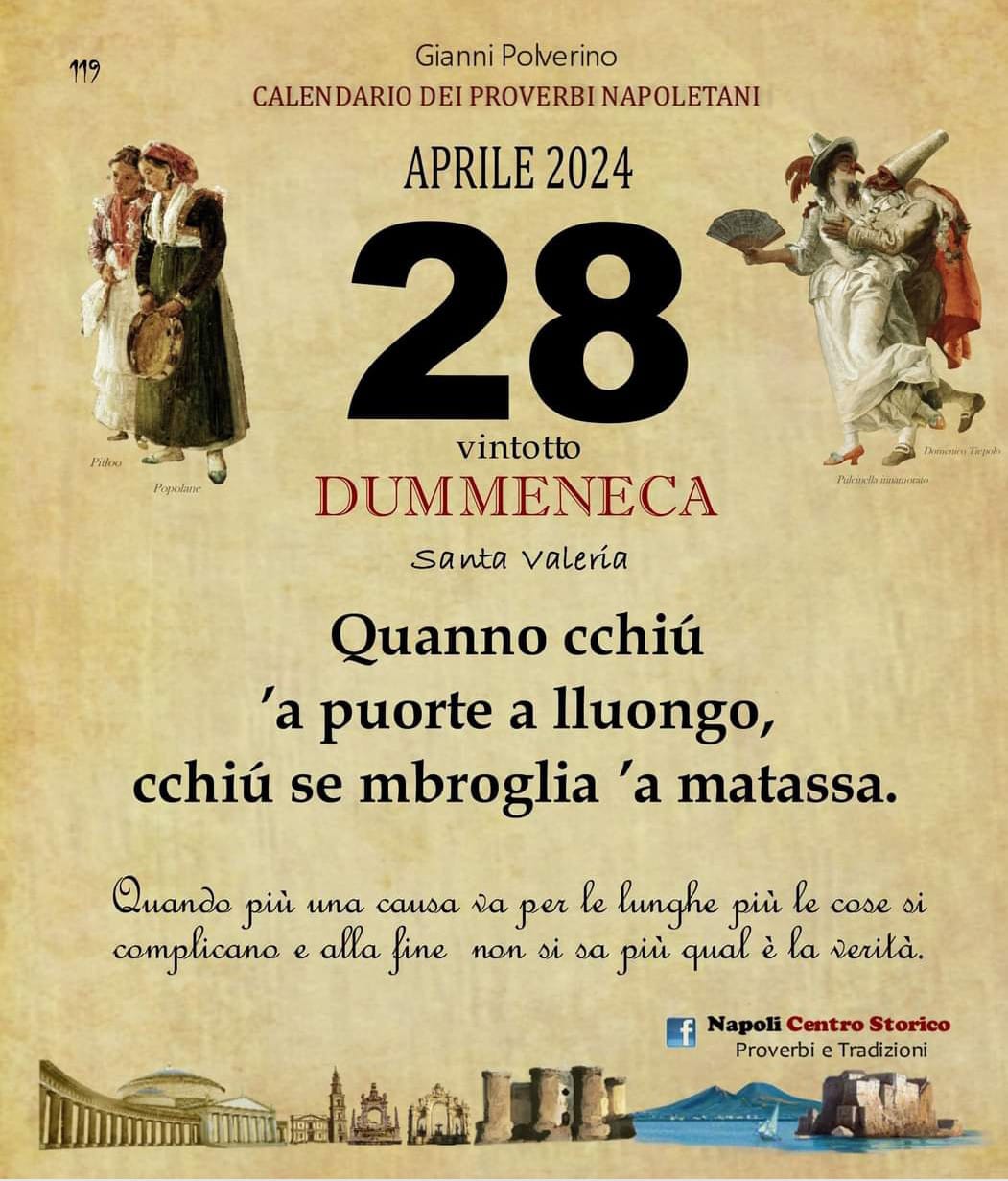




silverio lamonica1
5 Marzo 2021 at 11:11
Intendo soffermarmi un po’ sul seguente passaggio della esauriente e lineare esposizione del dr Santoro: “La Costituzione (…) garantisce il diritto all’istruzione e alla formazione privata, purché senza oneri per lo Stato, …”
L’autore fa riferimento all’art. 33 commi 3 e 4 della nostra Costituzione :
– Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato.
– La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
In prima battuta i Padri Costituenti ci hanno assicurato che lo Stato non deve dare contributi alle scuole private.
In seconda battuta lo Stato assicura piena libertà agli istituti privati, nonché parità di trattamento, per gli alunni che le frequentano, rispetto agli studenti delle scuole statali.
Secondo me, in tutto questo c’è una “contraddizione in termini” e qui mi sovvengono le “famose” circolari del Provveditore e del Ministero – dal contenuto spesso contraddittorio – per cui chiedevo lumi al carissimo amico Adolfo Gente, cui ho fatto cenno nel commento alla seconda parte del suo articolo illuminante su Ponzio Pilato.
Eh sì, perché è proprio il quarto comma – secondo me – che fornisce su un piatto d’argento “la scappatoia” alle scuole private di chiedere sovvenzioni allo Stato, per coprire almeno le spese da sostenere per gli stipendi e oneri relativi dei docenti da loro assunti. In caso contrario le famiglie dovrebbero sobbarcarsi un onere non indifferente.
Ci sarebbero poi da spulciare i vari articoli del Concordato tra Stato Italiano e Chiesa Cattolica in merito a tale argomento.
Certo, senza il Comma 4 di cui sopra, i nostri Padri Costituenti sarebbero stati ben più chiari, in materia di istruzione privata, “lavandosene definitivamente le mani” alla maniera dell’illustre personaggio dell’antica Roma (ma è solo una mia impressione, s’intende)…