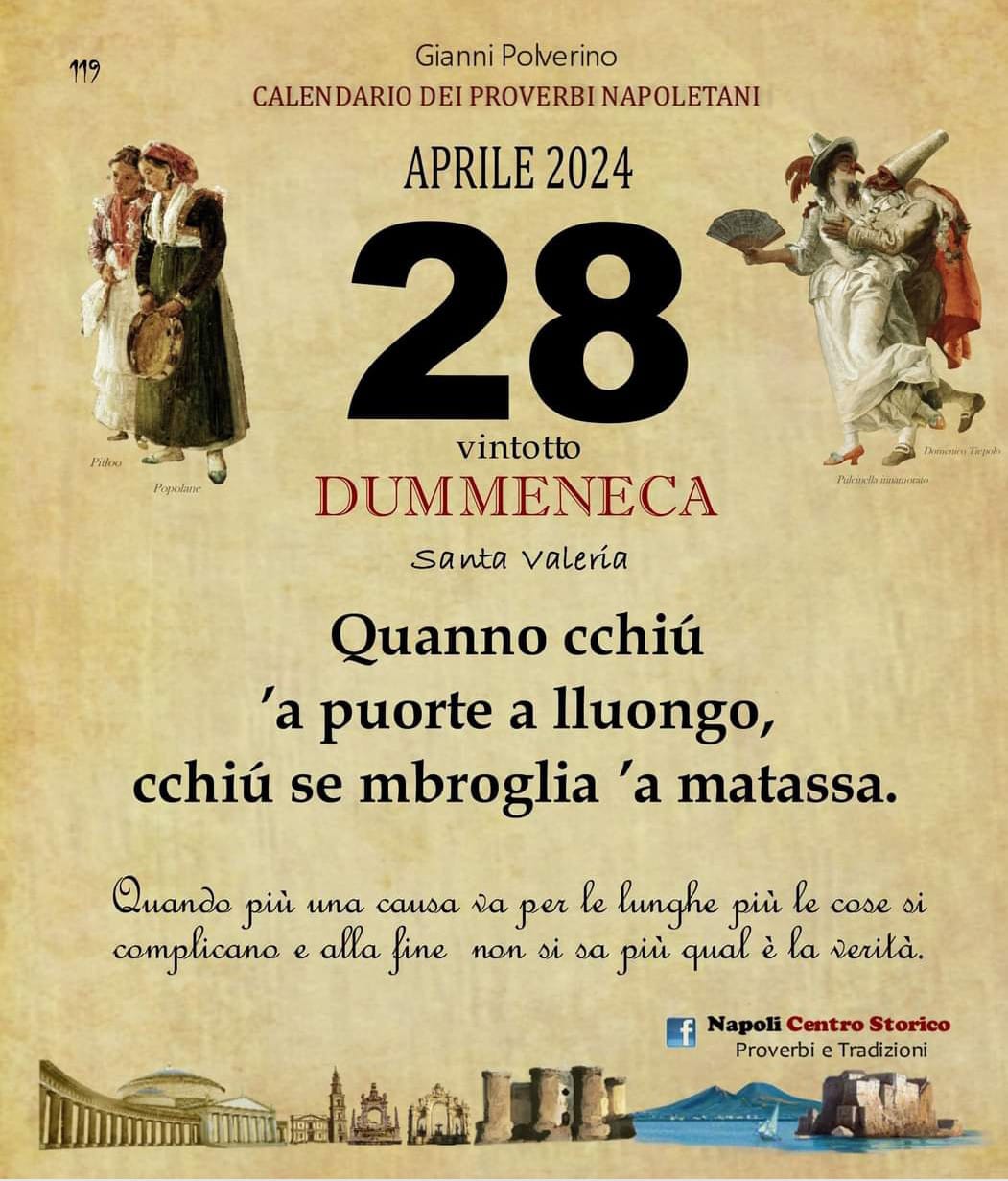di Rita Bosso
La pubblicazione degli articoli di Arturo Gallia (leggi qui e qui) e di Franco De Luca (leggi qui) sui saperi idrici mi ha indotto a rileggere gli scritti di Giuseppe Silvestri; i link sono in fondo alla pagina.
Silvestri, docente di storia oggi in pensione, è autore di numerosi studi sulla storia dell’isola d’Ischia: rigorosi, scevri da sensazionalismi, depurati da ovvietà; si è occupato specificamente di Ponza in “Ischia base navale inglese 1943-45”, Valentino ed.
In generale, che scriva di pesca o di agricoltura, Silvestri getta luce anche sulla storia di Ponza giacché gli ischitani che nel XVIII secolo si stabilirono a Ponza non avrebbero potuto non portarvi saperi, pratiche, tradizioni. Nel tempo, inevitabilmente, tali saperi sono stati adattati, curvati sulle caratteristiche del territorio colonizzato e si sono contaminati con altri saperi.
Palure o parule (ma anche siene) erano i terreni coltivati ad ortaggi della fascia costiera settentrionale dell’isola d’Ischia; qui, scrive Silvestri, “ gli interventi dell’uomo si erano limitati a costruire i pozzi con relative strutture per il funzionamento delle norie e le vasche di raccolta con i canali per l’irrigazione. Tutto in pietra di tufo verde e con intonaco di calce e lapillo. Altra opera dei contadini era costituita dalle “parracine”, che delimitavano alcune proprietà ma che avevano anche la funzione di proteggere le colture dai venti e dalla salsedine; i confini e le protezioni erano realizzati anche con siepi dette “mmarràske”, fatte di foglie di palma, di canne, dei cosiddetti “pennicilli” e soprattutto di rami di arbusti.”
Ogni podere aveva il pozzo; la presenza di un suolo ricco di acque calde indusse all’utilizzo della noria (dall’arabo na-oriah = ruota idraulica per irrigazione), macchina azionata da un asino, che consentiva di prelevare ingenti quantità di acqua; l’acqua veniva immessa in vasche (pischère) in cui si raffreddava e decantava.
“Ed allora dove si praticava un’agricoltura intensissima di ortaggi e soprattutto di pomodori furono realizzate le norie: macchine formate dal tamburo (ruota di trasmissione) con la parte centrale posta sulla sommità o bocca del pozzo e da vaschette (o secchi) che, fissate a due nastri o catene (la loro lunghezza era in relazione alla profondità del pozzo), discendevano vuote, si riempivano al momento dell’immersione e risalivano, facendo riversare l’acqua nel canale di raccolta, in un costante rinnovarsi di questo movimento circolatorio. Accanto al pozzo o anche ad una certa distanza si trovava una grande vasca, detta peschiera (pischera), in cui confluiva l’acqua dal canale di raccolta, dove evaporava e si raffreddava, prima di essere utilizzata per l’irrigazione.
Al centro del tamburo (o ruota), nei mozzi, passava un asse di ferro di forma quadrata che ad una distanza prestabilita riceveva il movimento da una corona tramite la cosiddetta “rota ‘e giégne” sulla quale era fissato una barra di legno collegata all’asinello (o mulo) che continuamente girava e azionava il congegno: all’animale erano applicati dei paraocchi, per togliergli la visuale e impedire che avesse la percezione del movimento circolare.
Il sistema aveva dunque una completa autonomia; il contadino, intento al suo lavoro, anche da lontano dava uno sguardo ed incitava l’animale, se rallentava il passo.”
Nelle zone in cui l’acqua era a soli tre, quattro metri di profondità, non era possibile utilizzare le norie e si attingeva direttamente con i secchi.
A Ponza, in assenza di falde acquifere profonde, i coloni ischitani dovettero rinunciare alla noria – con buona pace dell’asino – e inventarsi altri “ingegni”.
Domenico Musco descrive il sistema delle chiuse e della cannafeola, davvero ingegnosi: non bestemmiavano più gli asini ma i nipoti, costretti da nonne integerrime a tirare l’acqua dal pozzo e a innaffiare.
Noria, marraska: se parliamo di giardini e di irrigazione, inevitabilmente spuntano gli arabi. Franco De Luca esprime qualche perplessità sul turco (o arabo) che, tra un’azione piratesca e l’altra, costruisce un pozzo; come dargli torto? Ma forse il costruttore ha appreso la tecnica altrove, dai turchi, e poi l’ha messa in pratica a Ponza; forse la tartana ha dovuto sostare in porto per qualche giorno, in attesa che il levante si calmasse, e il turco benemerito ha spiegato al contadino autoctono come realizzare il pozzo, gli ha pure fatto un disegno; forse… chissà… i saperi, come già detto, si contaminano, si trasmettono, si adeguano: non stiamo mica scoprendo l’acqua calda!
Infatti oggi, al cospetto della bolletta di Acqualatina, bestemmiamo come turchi, in memoria del benemerito costruttore di pozzi.
http://www.larassegnadischia.it/Rassegna%202006/rass1-06/citara.html
http://ischialarassegna.com/rassegna/Rassegna2009/rass02-09/pisciariello.pdf
http://ischialarassegna.com/rassegna/Rassegna2008/rass0108/siene.pdf
http://www.larassegnadischia.it/rassegna2008/rass0208/orti.html